|
|
|
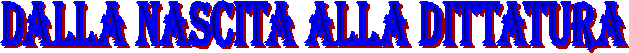
|
N |
el 1919 ci si rese conto che la
Belle époque era finita per sempre lasciando un’Europa disfatta e desolata
davanti ad una crisi economica senza precedenti. Il conflitto appena concluso era
stato ben diverso da quelli che l’avevano preceduto: contingenti enormi di
truppe avevano devastato vaste aree geografiche, stravolgendo l’assetto
dell’Europa e il suo sistema economico. Inoltre l’eco minacciosa della
rivoluzione bolscievica rappresentava un segnale chiarissimo della fine
dell’economia di tipo capitalistico-coloniale che aveva fino ad allora
dominato.
L’Italia aveva tratto dalla vittoria
grandi benefici, malgrado le fossero spettati pochi territori: il coronamento
dell’aspirazione unitaria, il nuovo ruolo nell’equilibrio europeo, la sicurezza
territoriale, che giungeva dopo quindici secoli di minacce e invasioni. La
maledizione che aveva sempre gravato sulla nazione – e che Metternich aveva
riassunto nel detto «l’Italia è un’espressione geografica» -sembrava svanita.
La fine del 1918 e l’inizio del 1919 passarono abbastanza tranquillamente,
anestetizzati dall’euforia della vittoria. In primavera le cose però
cominciarono ad evolvere, in peggio.
Durante la guerra alle truppe era
stato fatto ogni genere di promessa: soprattutto di avere, a guerra vinta,
terra da lavorare e posti nelle industrie. Il governo si era impegnato in
Parlamento, con relative proposte di legge, ma dopo mesi dalla fine della
guerra non era ancora accaduto niente. Lo stato sembrava essersi dimenticato
delle promesse fatte ai suoi uomini. I violenti scioperi e i moti che a marzo
scossero fabbriche e città dimostrarono che i reduci ricordavano benissimo
quelle promesse: i contadini del Sud occuparono le terre, gli operai del Nord
le fabbriche; gli effetti furono immediati: la produzione ebbe un crollo,
l’inflazione un’impennata e i generi di prima necessità cominciarono a
scarseggiare. I lavoratori e gli ex combattenti si sentivano traditi dai
politici, anche perché per i grandi industriali, commercianti e proprietari
terrieri la guerra era stata molto redditizia (Einaudi disse a proposito del
monopolio industriale delle grandi aziende:«Si è pagato dieci ciò che costava
cinque, lasciando lucrare cinque al fabbricante».), e a renderlo possibile era
stato lo Stato, tra l’altro evitando per le aziende belliche ogni controllo
sindacale e permettendo ai proprietari di spadroneggiare come non mai.
Anche i ceti medi attraversavano un
forte disagio: schiacciati fra le masse popolari e i «pescicani», videro
allontanarsi sempre di più l’alta borghesia dal loro orizzonte, mentre si
avvicinava lo spettro del proletariato (sarà proprio la classe media, carica di
rancori nei confronti del governo, dei «pescicani», dei «bolscevichi», a costituire
la prima forza del fascismo).
Quasi tutto il paese, insomma, era
affondato nella miseria e nella paura per il futuro (paura, stanchezza,
amarezze e disagi di ogni tipo saranno il terreno su cui si fortificherà il
fascismo).
Come conseguenza, nell’autunno-inverno
tra 1919 e 1920, chiamato «l’inverno rosso», in Umbria, Toscana, Emilia Romagna
e Lombardia il popolo si sollevò invocando la rivoluzione; gli industriali
vedendosi seriamente minacciati furono costretti a concedere un aumento dei
salari; in campagna però le retribuzioni scesero ancora, costringendo i
contadini a drammatici scioperi per lunghezza e conseguenze, ottenendo
l’adeguamento dei contratti e la possibilità di occupare le terre incolte. Ciò
non bastava però a far fronte alla crescente inflazione, che annullava in breve
tempo ogni conquista di operai e contadini.
Gli ex ufficiali congedati non
riuscivano a riconoscersi negli eventi che stavano dominando la loro nuova
esistenza: avevano perduto i benefici della vita militare e la potenza dell’
Italia era rimasta sulla carta. Per loro governo e Parlamento avevano operato e
stavano decidendo contro gli interessi della nazione, oltre che contro i loro.
|
I |
l dopoguerra era stato un brusco
risveglio anche per Mussolini. I socialisti lo disprezzavano, i moderati non lo
avevano in simpatia e la destra lo ignorava, esaltata dalla figura di
D’Annunzio, il capo carismatico di un seducente quanto improbabile misticismo
patriottico.
Mussolini capì che intorno a sé e al
suo giornale poteva raccogliere gran parte dei reduci, a patto di individuare
la strada sulla quale si sarebbero avviati volentieri. Egli la individuò, al
momento, in una sinistra nuova che non aspirasse a rovesciare lo stato, ma lo
socializzasse con strumenti diversi dal socialismo riformista. Il passaggio di
Mussolini dal socialismo al fascismo fu dunque graduale e motivato, tutt’altro
che un tradimento.
Il 23 marzo 1919 Mussolini fondò in
piazza San Sepolcro i Fasci di combattimento. In quel momento non dava molta
importanza al movimento appena sorto, credendo ancora che la miglior politica
fosse quella fatta attraverso il giornale e i partiti già esistenti. Nel suo
progetto i Fasci dovevano servire soltanto a tenere più legato il suo non
troppo omogeneo gruppo di sostenitori. Gli aderenti al movimento erano
interventisti, ex rivoluzionari di sinistra, ex arditi, intellettuali
futuristi, fra i quali Filippo Tommaso Martinetti, repubblicani ed esponenti dell’Unione socialista italiana,
di cui faceva parte Roberto Farinacci.
Nell’equilibrio del primo nucleo
fascista gli arditi avevano un peso particolare; truppe d’assalto speciali e
volontarie costituite nel 1917, erano visti come esempio estremo di spirito
guerriero (a tal proposito il generale E. Caviglia disse:«L’ardito vive
sparando e lanciando bombe a destra e sinistra, allegramente. Quando tornano
dall’azione questi soldati dicono tra loro: “e ho ammazzati sei, otto,
dieci…”Ognuno vanta il suo colpo di coltello e ne sperimenta di migliori. Tutto
ciò va benissimo in guerra, ma in pace? Ahimè, io vedo già cosa potrà fare
questa gente che non conosce più il valore della vita umana»). Alla fine della
guerra ce n’erano tra i 25 e i 30000. La maggior parte si schierò con i
fascisti, tra loro Giuseppe Bottai e Italo Balbo. Dagli arditi il fascismo
mutuò simboli e riti: il fez, il teschio, il motto «Me ne frego!», il grido «A
noi!» e l’inno “Giovinezza” (che era stato anche, con alcune variazioni nel
testo, una canzone goliardica).
I Fasci di combattimento si proposero
come la novità emergente della stagnante politica italiana, con due obbiettivi:
scalzare a destra i nazionalisti e superare a sinistra il Patto Socialista.
Inizialmente Mussolini si impegnò
poco nel nuovo movimento e solo a giugno venne elaborato un programma che
erroneamente è passato alla storia come «programma di S. Sepolcro». Esso
prevedeva: suffragio universale esteso a donne e diciottenni, assemblea
nazionale per scegliere tra monarchia e repubblica, abolizione del Senato,
giornata lavorativa di otto ore, minimi
salariali di Stato, modifica delle leggi assicurative, affidamento dei
trasporti alle organizzazioni proletarie, totale libertà di pensiero, di
parola, di stampa, sequestro dei beni delle congregazioni religiose, abolizione
dei titoli nobiliari, imposta progressiva sul patrimonio, revisione di tutti i
contratti per le forniture belliche, nazionalizzazione delle industrie di
guerra e istituzione di una milizia nazionale.
Uniti non dal programma, ma dalla
sete di violenza contro i «nemici della patria», i fascisti salirono per la
prima volta alla ribalta nazionale il 15 aprile 1919, quando attaccarono e
distrussero la sede dell’«Avanti!». Mussolini negò di essere il mandante o
comunque di avere organizzato l’azione, ma dichiarò che i fascisti si assumevano
tutta la responsabilità morale dell’episodio. Di questa situazione molto
preoccupato era lo stesso Mussolini, dal momento che non aveva nessun controllo
su arditi e futuristi , pur riuscendo a sembrare capo dei Fasci.
Il 12 settembre D’Annunzio con i suoi
legionari occupò Fiume; sulla questione Mussolini e i Fasci erano ovviamente
concordi con D’Annunzio, ciononostante Mussolini non aderì all’impresa, temendo
che questa potesse provocare una rivolta socialista con conseguenze molto
pericolose, e pensando soprattutto alle elezioni del novembre 1919. I risultati
di queste però furono tragici per lui e problematici per il Paese. I socialisti
passarono da 48 a 156 e sembravano sul punto di impadronirsi del potere con
violenti moti di piazza, scioperi e occupazioni che si susseguivano in maniera
sempre più incontrollata e incontrollabile. Assieme ai popolari avevano
ottenuto la maggioranza dei voti (54.1 %) e dei deputati (256 su 508), anche se
difficilmente avrebbero potuto allearsi, la vecchia classe dirigente liberale
era di fatto in minoranza. La lista fascista presentata a Milano subì una vera
disfatta: nonostante la presenza di nomi importanti come Marinetti, Vecchi e lo
stesso Mussolini ottenne solo 4.657 voti su 270.000 e nessun fascista andò in Parlamento.
Il 15 giugno 1920, dopo la caduta del
governo Nitti, tornò al potere l’anziano Giolitti. Costui per facilitare la
ripresa economica prese provvedimenti basati su una riforma tributaria che
premeva sulle classi privilegiate. La manovra sembrò funzionare: gli
investimenti stranieri salirono, l’inflazione scese e i salari vennero
adeguati. Purtroppo, però, gli investimenti esteri, nodo cruciale della
politica giolittiana, non durarono a lungo: la crisi che investiva ormai da più
di un anno le potenze europee non permise di mantenere l’ottimismo iniziale e
la riforma fallì. Le fabbriche furono costrette ad abbassare i salari, ridurre
gli organici o addirittura chiudere. Forti scioperi turbarono la penisola
quando si decise l’abolizione del calmiere e del prezzo politico del pane; intanto Giolitti aveva concesso agli
industriali un forte protezionismo doganale, che però andava a svantaggio dei
ceti agrari. Fu a questo punto che essi iniziarono a finanziare – o addirittura
ad ingaggiare – le squadre fasciste, nemiche sia del governo sia dei
socialisti.
A questo punto Mussolini si rese
conto che i tempi erano maturi: spinse ancora più a destra il fascismo e dette
il via libera allo squadrismo. Il «duce», come cominciavano a chiamarlo i suoi,
cercava il consenso dei ceti altoborghesi rurali e industriali, senza però
rinunciare a quello dei lavoratori; egli voleva soprattutto, al di là degli
ideali politici, conquistare il potere, con qualsiasi alleato e mezzo.
|
M |
ussolini sostanzialmente appoggiò il governo Giolitti, l’unico in
grado di tenere a freno i socialisti. Nel settembre 1920, durante l’occupazione
delle fabbriche, non si unì al coro di chi
rimproverava al governo di non aver usato la forza: contemporaneamente
non si mostrò ostile all’occupazione per non inimicarsi gli operai e appoggiò
le loro rivendicazioni salariali. Alla fine del 1920, poi, non contrastò la
decisione giolittiana di risolvere con la forza la questione di Fiume:
D’Annunzio e i suoi dovettero abbandonare la città sotto i bombardamenti e
anche da destra qualcuno cominciò ad accusare Mussolini di tradimento.
Giolitti, però, grazie a lui, aveva evitato una crisi internazionale e il
rischio di ulteriori disordini interni: i conservatori si convinsero che il
fascismo era un movimento patriottico e che non avrebbe portato nessuno
scompiglio politico e sociale, anzi.
Così,
alla fine del 1920, il progetto che solo un anno prima sembrava fallito era ora
a buon punto: con D’Annunzio e i suoi fuori gioco l’eredità del nazionalismo
era stata raccolta dai fascisti che nel frattempo stavano convincendo le
campagne, dove i cattolici e i socialisti avevano sempre dominato. Dopo il
fallimento dell’occupazione delle fabbriche, quando le sinistre e le loro formazioni
paramilitari erano in piena crisi, cominciarono ad operare violentemente le
squadre fasciste, iniziando una vera e propria guerriglia condotta secondo i
metodi dell’arditismo: assalivano l’avversario con assalti improvvisi che gli impedivano di riprendersi e di
mettersi in collegamento con i compagni. I fascisti, usando pistole, manganelli
e olio di ricino, si muovevano tranquillamente oltre la legalità. Bisogna dire
però che la violenza non era una prerogativa solo dei fascisti, ma era comune a
tutti i movimenti che tendevano a fare il popolo partecipe alla vita politica:
nazionalisti, comunisti, fascisti, socialisti o anarchici, tutti avevano in
comune la forza e lo scopo: sostituire le strutture dello stato liberale. Non
esistevano ancora associazioni o istituti per dare modo al popolo di essere
preso in considerazione. Esistevano solo organizzazioni di lavoratori che non
disdegnavano il ricorso alla violenza, a cui lo stato rispondeva spesso con
fucilate contro i manifestanti. La violenza era dunque l’unica arma che restava
al popolo: un mezzo certamente non giustificabile, ma certamente comprensibile
ed efficace in frangenti estremi. Se lo scontro fisico non riusciva quasi mai
ad affermare i propri diritti, poteva per lo mento mostrare all’altro la
propria esistenza e la sua drammaticità.
Lo squadrismo fu dunque un
atto da condannare, come ogni violenza, specie se organizzata e premeditata,
tuttavia bisogna distinguere la prima dalla seconda fase. Guglielmo Salvemini a
tal proposito si è espresso così: «Gli stessi atti di violenza dei fascisti
possono essere guardati con indulgenza. Dato che polizia e magistratura erano
incapaci di difendere i cittadini dallo strapotere delle organizzazioni
sindacali, questi stessi cittadini avevano il diritto di cercare di difendersi
per mezzo di metodi illegali. Un fascista doveva affrontare l’impopolarità, era
disposto alla violenza delle folle, rischiava di essere ferito o ucciso,
rischio che non era così alto come vorrebbe farci credere la propaganda
fascista, ma che era abbastanza concreto da far sbollire gli ardori ad un uomo
comune».
Gli squadristi erano per lo più
appartenenti alla media e piccola borghesia: molti erano ex ufficiali e molti
altri anche studenti. Se le finalità delle azioni attiravano nelle squadre
idealisti convinti e politici sognatori, erano invece i metodi a richiamare
teppisti e assassini, criminali a piede libero che avevano imparato le tecniche
dell’arditismo sotto le armi e cercavano, a guerra finita, una fonte di
sussistenza. Grazie ai finanziamenti di molti proprietari costoro ricevevano,
come squadristi, un compenso circa tre volte superiore a quello di un
bracciante. Grazie allo squadrismo il fascismo trovò nelle campagne il suo
ambiente naturale: i fasci di combattimento avevano sotto controllo le regioni
agricole più importanti e nel 1921 le organizzazioni fasciste cominciarono a
sostituirsi ai sindacati socialisti. Erano strutture di tipo nuovo, che
mettevano insieme proletari, contadini, possidenti e imprenditori: avversione
di classe, volontà di eliminare definitivamente il «pericolo rosso», desiderio
di rivincita e vendetta, spirito di avventura, interesse personale, desiderio
di farsi avanti nella vita sociale e politica, queste furono le matrici del
successo fascista nelle regioni agricole del paese.
|
D |
opo
il successo nelle campagne arrivarono i finanziamenti anche dai grandi
industriali e il fascismo sfondò anche nelle città settentrionali, soprattutto
grazie ai continui slogan e motti che venivano propinati alla gente.«Nel
fascismo è la salvezza delle nostre libertà» suonava borioso uno di questi
slogan, e il popolo volle crederci; l’abilità di Mussolini, gli errori dei
socialisti e dei liberali fecero il resto. Giolitti fu molto indulgente verso i
fascisti, pur ritenendo eccessivi il loro ardore e l’amor di patria; egli
voleva sfruttare la loro violenza per limitare il crescente potere dei due
partiti di massa (socialista e cattolico), che stavano mettendo in ombra quello
liberale. Riteneva infatti che solo i metodi fascisti avrebbero riportato i
socialisti all’atteggiamento collaborativi dell’anteguerra; nella sua ottica i
fascisti erano da considerare solo uno strumento, un forte ma stupido animale
da lavoro che una volta terminato il suo compito si sarebbe fatto ricondurre
nel suo recinto. Questo, dunque, il motivo che spinse Giolitti a far chiudere
un occhio ai prefetti e alle forze dell’ordine sulle azioni squadriste.
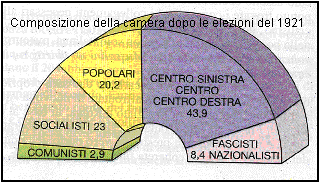 Si giunse così al 15 maggio 1921, giorno delle elezioni.
Durante il voto molte furono le illegalità, ma il risultato delle urne non fu
sostanzialmente falsato. Dalle elezioni
emerse una Camera stravolta: a sinistra c’erano 122 socialisti e 16 comunisti;
al centro 107 popolari, 26 socialisti riformisti, 41 democratici sociali, 24
democratici liberali, 36 democratici italiani sostenitori di Nitti, 42
democratici sostenitori di Giolitti; a destra si trovavano 21 liberali ispirati
a Calandra, 11 nazionalisti, 23 agrari e 35 fascisti, tra cui, oltre Mussolini,
Bottai, Farinacci e Grandi.
Si giunse così al 15 maggio 1921, giorno delle elezioni.
Durante il voto molte furono le illegalità, ma il risultato delle urne non fu
sostanzialmente falsato. Dalle elezioni
emerse una Camera stravolta: a sinistra c’erano 122 socialisti e 16 comunisti;
al centro 107 popolari, 26 socialisti riformisti, 41 democratici sociali, 24
democratici liberali, 36 democratici italiani sostenitori di Nitti, 42
democratici sostenitori di Giolitti; a destra si trovavano 21 liberali ispirati
a Calandra, 11 nazionalisti, 23 agrari e 35 fascisti, tra cui, oltre Mussolini,
Bottai, Farinacci e Grandi.
Mussolini capì che, giunto
in Parlamento, doveva riqualificare il fascismo, rassicurare la borghesia
timorosa di ulteriori violenze e poi puntare a mete più ambiziose della
semplice distruzione del socialismo. Come prima cosa doveva evitare un accordo
fra socialisti e popolari contro il suo schieramento. A tal fine in giugno
cominciò trattative segrete con entrambi gli schieramenti per un patto di
pacificazione. Quando lo si seppe lo squadrismo si ribellò, perché quel patto
avrebbe segnato la sua fine, dovuta alla sua inutilità. Ma Mussolini,
considerando quell’accordo fondamentale impose la sua volontà. Il patto di
pacificazione venne firmato il 3 agosto: fascisti e socialisti (i popolari si
erano ritirati) si impegnavano a cessare ogni azione illegale. Mussolini, però,
rischiando una scissione all’interno del movimento nel giro di poco meno di tre
mesi definì l’accordo prima «una svolta storica», poi «un accordo temporaneo»
ed infine «un episodio retrospettivo».
Nell’autunno del1921
decise di trasformare il movimento in partito, per controllarlo meglio,
normalizzarlo all’occhio dell’opinione pubblica e dargli un nuovo programma.
Questo fu pubblicato sul «Popolo
d’Italia» l’otto ottobre 1921: restaurazione dell’economia nazionale,
valorizzazione dello Stato, incremento delle attività produttive, necessità di
un sindacato unico, linea dura contro il socialismo. Questa manovra non fu
facile, specie perché ostacolata dalle ambizioni e dalla dissidenza dei vari
capi locali (o «ras» come si facevano chiamare); il movimento fascista appariva
ancora un agglomerato anarchico più che
un partito conservatore. Mussolini sfidò l’opposizione presentando le sue
dimissioni dalla giunta esecutiva del movimento, sapendo che nessuno lo avrebbe
potuto sostituire; queste furono infatti respinte. La trasformazione da
movimento a PNF avvenne durante il congresso, svoltosi a Roma, del 7 novembre
1921, nel quale Mussolini espresse i tre punti cardinali del suo programma: un
irriducibile antisocialismo, il rifiuto della Carta del Carnaro dannunziana
come base costituzionale, l’apertura verso la chiesa. Gli squadristi vennero
rassicurati: sarebbero rimasti il nerbo del partito e vennero inglobati nel PNF
come un contingente paramilitare. Mussolini dovette risolvere anche il problema
della monarchia, la cui abolizione era stata uno dei punti del programma
sansepolcrista: non poteva fare una rivoluzione che comportasse la
detronizzazione dei Savoia, perché il suo repubblicanesimo urtava contro
l’ideale comune della borghesia che era monarchca. Così in un discorso a Udine
sostenne che la monarchia non osteggiava il fascismo, quindi il fascismo non
avrebbe tentato di destituire la monarchia, «unica continuità storica
d’Italia». Allo stesso tempo inviò al re un vero e proprio ultimatum: se non
avesse affidato il potere a chi si era dimostrato in grado di gestirlo
adeguatamente, un altro re avrebbe potuto presentarsi sulla scena.
Nel 1922 l’instabilità del
Paese e l’incapacità del governo raggiunsero l’apice: vista la debolezza dello
stato i fascisti sostituirono alla tecnica delle piccole squadre quella di
concentrare migliaia di uomini e occupare e devastare intere città. Il primo di
agosto le sinistre commisero un errore fatale: proclamarono uno sciopero a
tempo indeterminato contro il fascismo. La borghesia si spaventò per la
possibilità di un ritorno agli scioperi di due anni prima e il fascismo poté
presentarsi così come suo difensore. I fascisti riuscirono a fare funzionare
l’essenziale, facendo miseramente fallire l’iniziativa: era la sconfitta definitiva
delle sinistre. Ormai rimaneva da battere solo il governo, presieduto da Facta.
Facta in ottobre offrì a Mussolini la possibilità di partecipare a un nuovo
ministero guidato da Giolitti, Calandra o da lui stesso, sperando che la
partecipazione all’esecutivo avrebbe frenato la violenza e la illegalità
fasciste. Mussolini rifiutò: non voleva entrare in un governo, voleva farlo
lui. Così rispolverò una vecchia idea di D’Annunzio, la «marcia su Roma», per
dimostrare la potenza del fascismo. Il 25 ottobre del ’22 dettò una sorta di ultimatum allo stato e dette il via
alle operazioni: sotto il comando dei quadrunviri Balbo, De Bono, Bianchi e De
Vecchi quattro colonne fasciste avrebbero dovuto convergere su Roma, mentre in
ogni città le squadre dovevano occupare i punti strategici. Mussolini giocò in
quei giorni la sua partita più abile: trattò con tutti (Calandra, Facta, Nitti,
Giolitti, Orlando), illudendo la classe politica liberale di essere disposto ad
un aggiustamento costituzionale, intrattenne rapporti con esercito e
massoneria, incoraggiando i più decisi all’azione armata. Mussolini insomma
confuse il più possibile le carte, facendo una «rivoluzione diplomatica», o per
telefono, come disse Balbo in uno scatto d’ira quando si rese conto che il duce
considerava l’aspetto militare poco più che una parata, e aveva ragione. Sapeva
bene, infatti, che poche migliaia di
soldati avrebbero potuto comodamente fermare i fascisti, se soltanto ne
avessero ricevuto l’ordine. Il 28 ottobre Facta presentò le dimissioni al re,
che le respinse. Il governo a quel punto dichiarò lo stato d’assedio: le
autorità militari e i prefetti avrebbero dovuto opporsi con la forza alle
squadre fasciste. Ma il re non appose la sua firma all’ordine: Mussolini aveva
messo Vittorio Emanuele III nelle condizioni di scatenare una guerra civile o
di affidare a lui il governo; ciò accadde il 30 ottobre.
Il primo governo
|
P |
er
evitare trattative lunghe e difficili che lo avrebbero portato a fare troppe
concessioni ai partiti e a un parlamentarismo che voleva far dimenticare,
Mussolini si era rivolto direttamente agli uomini. I fascisti assunsero
direttamente tre ministeri fondamentali (Giustizia, Finanze e Terre liberate) e
Mussolini personalmente si pose a capo di Esteri e Interni. I nazionalisti
ebbero solo un ministero (Colonie), popolari e democratici due ciascuno (Tesoro
e Lavoro, Lavori pubblici e Industria), l’Agricoltura fu assegnata a un
liberale e le Poste a un demosociale. Il governo fascista venne tranquillamente
approvato grazie anche al discorso «del bivacco» tenuto da Mussolini il 16
dicembre. Inoltre la situazione economica degli anni 1922-25 aiutò
l’assestamento fascista. Nei primi anni di potere il governo riuscì a eliminare
il disavanzo sociale con una rigida politica di contenimento delle spese.
Mussolini non esitò a favorire sfacciatamente la classe imprenditoriale. Dopo
il decreto contro la nominatività dei titoli (10 novembre 1922), altri decreti
stabilirono l’abrogazione del blocco dei fitti (7 gennaio 9123), la
privatizzazione dei telefoni (8 febbraio), l’abolizione del monopolio statale
delle assicurazioni sulla vita (29 aprile). Si stabilì il principio delle otto
ore lavorative, che effettivamente fu applicato solo dieci anni dopo. Il 21 novembre
1923 infine i sindacati fascisti e la Confederazione dell’industria arrivarono
all’accordo di palazzo Chigi, impegnandosi a non scendere in conflitti di
lavoro, ma a dirimere ogni controversia con la mediazione del governo.
Mussolini si applicò
particolarmente alla normalizzazione del fascismo integrandolo nello Stato.
Pose infatti la massima cura nel rafforzare l’autorità statale, soprattutto
quella dei prefetti e dell’esercito, ma affiancandole organismi fascisti. Nel
gennaio 1923 vennero istituiti il Gran Consiglio del Fascismo e la Milizia
Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN). Il Gran Consiglio venne definito
come supremo organo coordinante e integrante tutte le attività del regime. In
teoria avrebbe dovuto essere consultato per ogni questione di rilevante
interesse nazionale, ma in realtà non aveva poteri. Nelle intenzioni di
Mussolini esso aveva tre compiti non dichiarati: dare soddisfazione e
un’apparenza di potere ai capi fascisti; dare l’impressione di una possibilità
di dibattito all’interno del PNF; affiancare al consiglio dei ministri
un’istituzione esclusivamente fascista.
La Milizia, invece,
nasceva dallo scioglimento delle squadre, ma ne conservava l’organizzazione e
ne ereditava la missione; poteva considerarsi un esercito di partito, che
addirittura non doveva prestare giuramento al re, ma a Mussolini. Solo nel 1924
sarebbe entrata a far parte delle forze armate, giurando al re.
Rinnegando
l’anticlericalismo e l’ateismo giovanili Mussolini curò meticolosamente i
rapporti con la Chiesa. Fu principalmente con il cardinale Pietro Gasparri che
Mussolini trattò le questioni inerenti la Santa Sede. Il Partito Popolare stava
politicizzando troppo i cattolici, scontentando la Chiesa che non voleva altro
che un governo che le lasciasse ampia libertà di movimento, specie nelle
scuole. Il Vaticano da tempo mal sopportava le idee di don Sturzo, per il quale
i fascisti erano «neri figuri illiberali e anticristiani», mentre il Vaticano e
Mussolini pensarono subito di sfruttarsi a vicenda.
Il primo incontro segreto
tra Mussolini e Gasparri avvenne il 20 gennaio 1923, quando Mussolini dichiarò
la volontà di risolvere la delicata questione romana (a ciò fu spinto solo
dalla ragion di stato, dal momento che solo con l’appoggio dei cattolici il
fascismo avrebbe potuto avere un potere assoluto). A contribuire ulteriormente
all’avvicinamento tra le due parti fu la riforma della scuola operata nel 1923
da Giovanni Gentile, che reintroduceva l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole primarie. La Chiesa apprezzò inoltre il fatto che fosse stata
dichiarata l’incompatibilità fra fascismo e massoneria, ai cui membri erano
state comminate numerose scomuniche sin
dal 1738. Oltre a ciò venne riconosciuta l’Università Cattolica, vennero
stanziati 3 milioni di lire per essa e regalati 600 quadri alle chiese
danneggiate dalla guerra, furono emanate delle leggi a favore dei sacerdoti, la
polizia eliminò il controllo sulle affissioni in chiesa e si dispose che il
crocifisso venisse affisso in ogni aula scolastica e di tribunale e negli
uffici pubblici. Come segno ulteriore del fervore con cui Mussolini voleva
avvicinarsi alla Santa Sede, faceva nel frattempo picchiare e bastonare
numerosi cattolici in giro per l’Italia la cui colpa era solamente quella di partecipare
a manifestazioni con le bandiere delle loro associazioni. Tale azione raggiunse
il culmine il 23 agosto 1923 quando i fascisti uccisero don Giovanni Minzioni,
eroe di guerra, antifascista e temuto organizzatore di manifestazioni
cattoliche.
Il delitto Matteotti e la dittatura
|
P |
er
le elezioni del 6 aprile 1924 Mussolini formò una lista in cui erano presenti
diversi liberali, mentre Giolitti si presentò con una lista propria. Se
Mussolini da un lato voleva che si svolgessero regolarmente, per permettere una
maggior affluenza alle urne, dall’altro ordinò pestaggi contro i fascisti
dissidenti che avevano presentato liste proprie. I ras non fecero distinzioni:
molti comizi vennero impediti, diversi oratori picchiati, numerose sezioni
avversarie distrutte, alcuni giornali incendiati. Lo stesso Giolitti definì la
vicenda elettorale una «torbida avventura condotta con metodi indegni di un
paese civile».
Alle urne andò il 63,8 %
degli elettori: la lista di Mussolini vinse con 4.304.936 voti più 347.552 di una
lista d’appoggio. Mussolini invitò gli avversari a collaborare, dal momento che
non avrebbe tollerato alcun ostruzionismo. L’opposizione trovò un leader in
Giacomo Matteotti. Deputato dal 1919 e segretario del Partito Socialista dal
1922, non aveva mai avuto dubbi sulla necessità di combattere il fascismo a
oltranza. Denunciò con decisione le violenze fasciste compiute sotto le
elezioni, proponendo che esse fossero annullate. Il voto fu naturalmente
contrario. Matteotti però polemizzò ancora contro Mussolini sfidando ogni
minaccia (assieme a lui parlò anche Giovanni Amendola). La situazione in
Parlamento era molto tesa e Mussolini tentò di sdrammatizzarla (7 giugno). Alla
camera si dimostrò molto conciliante verso le opposizioni, riaffermò la
validità delle elezioni e affermò che da quel giorno il Paese sarebbe tornato alla normalità. Tre giorni dopo
Matteotti veniva rapito e assassinato. Il suo cadavere fu trovato due mesi
dopo.
Gli esecutori erano stati
gli squadristi appartenenti alla Ceka (gruppo “segreto” di squadristi
prettamente usato da Mussolini per i pestaggi e per «dare una lezione». Il nome
le conferiva una fama terribile; evitava generalmente di uccidere i suoi
bersagli, limitandosi a forte violenza fisica che doveva stroncare le
resistenza psicologica dell’avversario. L’organizzatore del gruppo era il
segretario amministrativo del partito, Giovanni Marinelli, che ne rispondeva
direttamente al duce), coperti da alti funzionari del partito. Gli storici sono
a tutt’oggi scettici nel dire che sia stato Mussolini a ordinare l’atroce
delitto: dicono infatti che Mussolini a quei tempi era troppo astuto e intento
a raggiungere il potere per compiere un gesto che arrecò gravi danni al
fascismo (disse anche:«Solo un mio nemico, che da lunghe notti avesse pensato a
qualcosa di diabolico, poteva effettuare questo delitto»); una delle ipotesi
infatti è che sia stato organizzato da estremisti all’interno del PNF contro
Mussolini, scontenti della troppa «mitezza» del duce. Il più grave danno per il
partito fu che Mussolini non poté portarvi all’interno alcuni socialisti
riformisti, dovendo altresì optare per la dittatura prima del previsto. Altra
ipotesi fondata è che il delitto sia stato organizzato negli ambienti
loscamente affaristici del sottogoverno fascista che Matteotti stava per
denunciare in Parlamento. Comunque la tesi ancora più accreditata è che sia
stato Mussolini, pronunciando parole ambigue, cioè senza dare un preciso
ordine, dicendo:«Cosa fa questa Ceka? Quell’uomo
dopo quel discorso non dovrebbe più circolare». Marinelli e Dumini (altro uomo
di punta della Ceka) avrebbero preso queste parole per un ordine e organizzato
il delitto all’insaputa del duce.
Comunque fosse andata la
responsabilità morale del delitto fu di Mussolini e del clima di violenza
contro gli avversari che aveva instaurato per placare la sua sete di potere. Il
13 giugno si seppe che gli autori del delitto erano fascisti e un’ondata di
sdegno invase il fascismo e Mussolini; molti iscritti lasciarono il partito,
chiedendo un nuovo governo. Nei giorni seguenti Mussolini fece di tutto per
accrescere l’immagine legalitaria del governo: per mise l’arresto di due suoi
stretti collaboratori, implicati nel delitto e del direttore del giornale
fascista “Corriere Italiano”, proprietario dell’automobile su cui era avvenuto
il delitto. Sarebbe stato il momento ottimale per un’insurrezione popolare,
perché il governo fascista non era mai stato così debole, ma gli oppositori non
furono all’altezza della situazione e non seppero fare altro che «ritirarsi
sull’Aventino»: il 27 giugno decisero
di lasciare il Parlamento finché non fosse stata ristabilita la legalità.
L’opposizione chiese al re lo scioglimento della Camera e nuove elezioni. Il re
temette che tale decisione avrebbe portato ad una guerra civile, e non accolse
la richiesta.
Il 12 settembre un
antifascista uccise a Roma il deputato fascista Armando Canalini e questo
permise ai fascisti di avere il loro martire e scatenare una nuova ondata di
violenza.
Il 27 dicembre Giovanni
Amendola che dirigeva “Il Mondo” pubblicò un memoriale in cui si diceva:«Tutto
quanto è successo è avvenuto sempre per la volontà diretta o la complicità del
duce». Si scatenò un’altra ondata di sdegno che sembrò fatale al governo, ma il
31 dicembre ci fu la svolta decisiva per la nascita del regime fascista: 33
consoli della Milizia, istigati da Balbo, andarono da Mussolini dicendo che se
non si fosse deciso a stroncare le opposizioni lo avrebbero «sconfessato». Mussolini sapeva che quegli uomini erano
assai più pericolosi dell’opposizione e – se non fossero riusciti a rovesciarlo
direttamente – avrebbero potuto creare un clima insopportabile che avrebbe
finito per travolgerlo. Promise quindi che il 3 gennaio 1925 alla riapertura
della Camera avrebbe risolto il problema. E così fece. Pronunciò alla Camera un
discorso che andava dritto al punto, elencò tutti gli sforzi fatti per
pacificare il Paese dopo il delitto Matteotti, infine disse che «nelle
quarantott’ore successive a questo mio discorso la soluzione sarà chiarita a
tutta l’area». Erano le 16.10; nella notte partirono i telegrammi ai prefetti
con un elenco di misure repressive; nei giorni seguenti furono chiusi circa 400
circoli, gruppi, esercizi pubblici considerati ostili e vennero arrestati 111
sovversivi. Era solo l’inizio, entro la fine del 1926 sarebbero state emanate
tutte le leggi liberticide e sciolti gli altri partiti.